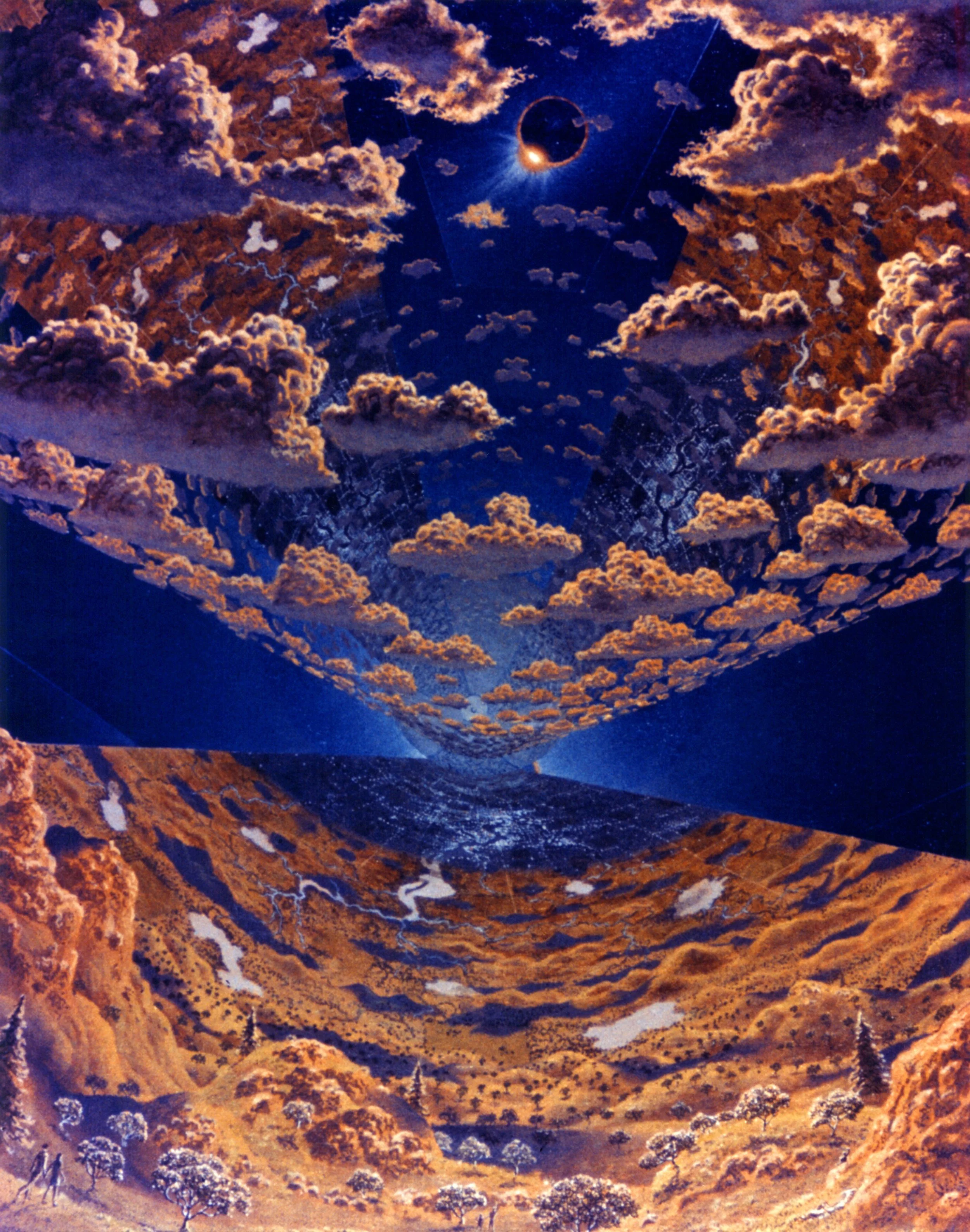“L'infanzia non ha tempo. Man mano che gli anni passano bisogna conservarla e conquistarla, nonostante l'età.”
— Emmanuel Mounier
“Non è mai troppo tardi per avere un’infanzia felice.”
— Richard Bandler
Una delle cose su cui sono più d’accordo con Richard Bandler, uno dei due co-fondatori della programmazione neuro linguistica è questa affermazione, oltre alle seguenti.
“Sono un analista interpersonale e con il passare degli anni sono sempre più soddisfatto della scelta di metodo compiuta all’epoca.”
“L’assunto di base di questo orientamento è che l’incontro psicoanalitico è costruito da due partecipanti attivi, due soggettività-paziente e analista che danno forma e sostanza al dialogo. Secondo Sullivan, il principale autore dell’approccio interpersonale, ogni individuo costruisce la propria personalità sulle interazioni che instaura con gli altri. Pur riconoscendo il suo tributo a Freud, egli escludendo la metafora libidica, era solito affermare : “provo molto più interesse per quello che può essere fatto ora, che non per quello che è accaduto in passato”.
Questa affermazione riassume egregiamente il modo di porsi del terapeuta che usa la relazione come strumento di cambiamento. Non tanto per andare a indagare nei vissuti trascorsi del paziente come un detective, quanto per affrontare la situazione vissuta nel qui e ora. Proprio perché è ormai accettato che l’individuo sia frutto della società e dei sistemi collettivi a cui appartiene, il risultato di un numero infinito di campi di interazione interpersonale che lo circondano, la visione dinamica ed intersoggetiva del Sé, costruito nella gradazione del dialogo Sé-Altro, risulta essere attuale e di grande interesse da un punto di vista terapeutico. Quello ideato da Sullivan è un sistema innovativo che opera la sostituzione presente nel modello classico, quello più conosciuto e stereotipizzato, utilizzato sovente nei film, dell’analista come osservatore con un modello dell’analista come partecipante in un’attività condivisa insieme al paziente.
Contravvenendo il modello classico, del medico che osserva il malato sdraiato sul lettino, questo setting è caratterizzato da due persone che si parlano, si confrontano vis a vis seduti in poltrona.
L’idea di partecipazione reciproca all’interno della seduta è finita per diventare parte integrante della cultura generale della psicanalisi, accettata oramai uniformemente. Il terapeuta interpersonale si distingue dal suo omologo “classico” perchè non guarda quello che c’è dietro ai dati, quanto ai dati stessi. Questo modello parte dal presupposto che ciascuno di noi, impara a conoscere il mondo esterno a partire dal continuo rapportarsi alla propria madre. In particolar modo, attraverso il legame che stabilirà con il seno, fonte di nutrimento, calore, contenimento.
Sullivan utilizzava il concetto di “validazione consensuale” come strumento per aiutare il paziente a distinguere tra ciò che è reale e appropriato e ciò che non lo è. Questo approccio culturale inoltre, utilizza l’empatia come strumento conoscitivo. Possiamo immaginare l’empatia come la capacità del terapeuta di sintonizzarsi con il mondo interiore del paziente. Come dice Gill (1983) chi aderisce al paradigma interpersonale non può non attribuire al terapeuta una profonda partecipazione alla situazione analitica. Partecipazione che è rigorosamente determinata e limitata dal materiale presentato dal paziente nella situazione terapeutica. Ampliando la consapevolezza del paziente nei confronti della sua vita, si giunge a quella che Sullivan chiamava “un’espansione del Sè”.
A questo punto si può confidare nelle capacità del paziente di cambiare la sua vita secondo i suoi canoni personali. Con buona approssimazione si può sostenere che giunti a questo punto la terapia è arrivata alla fase conclusiva, mentre è appena agli inizi la nuova vita del paziente. Mentre per la teoria classica la domanda che il terapeuta deve porsi è: “che cosa significa veramente ciò?” per la scuola interpersonalista la questione è piuttosto:
“Cosa sta effettivamente accadendo qui?”
Diversamente da ciò che sosteneva il pensiero classico sostiene che l’attività psichica non è orientata alla soddisfazione della libido e delle pulsioni, ma principalmente alla soddisfazione del bisogno di contatto e sicurezza.
Differentemente da Freud egli, nello sviluppo della personalità normale e patologico, attribuisce una funzione predominante alle determinanti socio-culturali e più precisamente ai rapporti interpersonali.
Secondo Sullivan il carattere primario dei bisogni di contatto e sicurezza, si rende particolarmente evidente nel rapporto complementare madre-bambino in cui al bisogno del piccolo di essere nutrito e protetto corrisponde il bisogno complementare della madre di accudire e nutrire. Il bisogno del bambino di essere nutrito e quello complementare della madre di offrire nutrimento acquistano sin dall’inizio un significato interpersonale e interattivo: infatti il bambino con il suo pianto e i suoi vocalizzi non reclama soltanto cibo, ma anche la presenza della madre e delle sue amorevoli cure, ossia un nutrimento oltre che organico anche psicologico e relazionale. In ultima analisi la filosofia di Sullivan accusa la psicoanalisi tradizionale di trascurare quella caratteristica umana che è la ricerca e forse possiamo anche dire il bisogno delle relazioni. Egli rifiuta di spiegare la psicopatologia in termini di meccanismi intrapsichici e preferisce orientarsi sulle dinamiche sottostanti alle relazioni interpersonali.